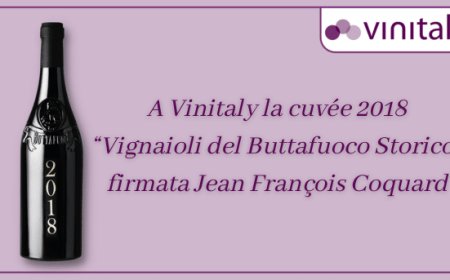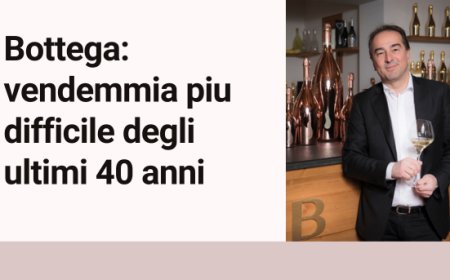Turismo lento di cammini e sentieri, un'opportunità per la scoperta del vino e il legame con il territorio
L’enoturismo abbraccia sempre più la filosofia del viaggio lento, etico e sostenibile, crescono i progetti per la riqualificazione dei cammini e sentieri esistenti e per la realizzazione di nuovi itinerari per attrarre sempre più viaggiatori nei territori dalla vocazione e tradizione vitivinicola

 Negli ultimi anni in Italia sta crescendo l’attenzione per il mondo dei “cammini” e del “turismo lento”, una dimensione fortemente spinta a livello globale dalla pandemia che con le sue restrizioni ha dato slancio ad un modo di intendere il viaggio fino a poco tempo fa relegato a nicchie di esploratori. Si iniziano a mettere in campo sempre più progettualità, anche nel mondo enoico, a testimoniare il profondo cambiamento che sta interessando il turismo enogastronomico. I viaggiatori focalizzano le loro ricerche non solo sulle destinazioni ma anche sugli itinerari che diventano esperienza antropologica dei luoghi, da raggiungere in chiave etica e sostenibile, prediligendo modalità che tengono conto delle fragilità e delle esigenze delle realtà territoriali. I numeri confermano che lo slow tourism non rappresenta una moda passeggera ma un trend destinato a consolidarsi dal momento che abbraccia fette di mercato sempre più ampie. Lo prenderebbe in considerazione il 54% dei potenziali viaggiatori, percentuale ancora molto lontana dalle tradizionali vacanze al mare (82%) o viaggi culturali (76%), ma ormai praticamente alla pari con il turismo enogastronomico (55%).
Negli ultimi anni in Italia sta crescendo l’attenzione per il mondo dei “cammini” e del “turismo lento”, una dimensione fortemente spinta a livello globale dalla pandemia che con le sue restrizioni ha dato slancio ad un modo di intendere il viaggio fino a poco tempo fa relegato a nicchie di esploratori. Si iniziano a mettere in campo sempre più progettualità, anche nel mondo enoico, a testimoniare il profondo cambiamento che sta interessando il turismo enogastronomico. I viaggiatori focalizzano le loro ricerche non solo sulle destinazioni ma anche sugli itinerari che diventano esperienza antropologica dei luoghi, da raggiungere in chiave etica e sostenibile, prediligendo modalità che tengono conto delle fragilità e delle esigenze delle realtà territoriali. I numeri confermano che lo slow tourism non rappresenta una moda passeggera ma un trend destinato a consolidarsi dal momento che abbraccia fette di mercato sempre più ampie. Lo prenderebbe in considerazione il 54% dei potenziali viaggiatori, percentuale ancora molto lontana dalle tradizionali vacanze al mare (82%) o viaggi culturali (76%), ma ormai praticamente alla pari con il turismo enogastronomico (55%).  Nel 2021 in Italia sono state distribuite ben 59mila credenziali, ossia passaporti che attestano lo status di viaggiatore lento, contro le 23mila del 2017. Un italiano su quattro ha vissuto almeno un’esperienza di turismo lento, dai piccoli borghi, all’escursionismo naturalistico, alle mete enogastronomiche, e il 43% è interessato a rifarlo in futuro, a testimoniare la volontà di recuperare quella che nell’antichità era una ritualità per filosofi, poeti, marciatori e pellegrini. A spingere in questa direzione è stato innanzitutto il desiderio di ritrovare il proprio benessere psicofisico, seguito dalla volontà di esplorare e scoprire nuovi luoghi, stare a contatto con la natura. Ad essere attratte da questo nuovo approccio al viaggio sono un po’ tutte le generazioni, il 66,9% dei camminatori infatti ha dai 30 ai 60 anni e le donne nel 2021 sono state il 50,4% del totale superando gli uomini. Questo nuova filosofia del viaggiatore, che vuole andare alla ricerca dell’Italia più nascosta, aiutare le economie locali e aumentare la sensibilità per la tutela dei luoghi, delle popolazioni che le abitano e delle loro tradizioni, mettendo al centro aspetti emotivi e relazionali, sta favorendo processi di riprogettazione e rinnovamento del turismo e dell’ospitalità. In questa direzione si stanno muovendo Governo, Istituzioni regionali e locali che hanno deciso di investire sul turismo lento come strumento indispensabile alla promozione efficace e sostenibile del territorio, alla destagionalizzazione dell’offerta, al contrasto del fenomeno di spopolamento delle aree interne e alla creazione di nuovi posti di lavoro.
Nel 2021 in Italia sono state distribuite ben 59mila credenziali, ossia passaporti che attestano lo status di viaggiatore lento, contro le 23mila del 2017. Un italiano su quattro ha vissuto almeno un’esperienza di turismo lento, dai piccoli borghi, all’escursionismo naturalistico, alle mete enogastronomiche, e il 43% è interessato a rifarlo in futuro, a testimoniare la volontà di recuperare quella che nell’antichità era una ritualità per filosofi, poeti, marciatori e pellegrini. A spingere in questa direzione è stato innanzitutto il desiderio di ritrovare il proprio benessere psicofisico, seguito dalla volontà di esplorare e scoprire nuovi luoghi, stare a contatto con la natura. Ad essere attratte da questo nuovo approccio al viaggio sono un po’ tutte le generazioni, il 66,9% dei camminatori infatti ha dai 30 ai 60 anni e le donne nel 2021 sono state il 50,4% del totale superando gli uomini. Questo nuova filosofia del viaggiatore, che vuole andare alla ricerca dell’Italia più nascosta, aiutare le economie locali e aumentare la sensibilità per la tutela dei luoghi, delle popolazioni che le abitano e delle loro tradizioni, mettendo al centro aspetti emotivi e relazionali, sta favorendo processi di riprogettazione e rinnovamento del turismo e dell’ospitalità. In questa direzione si stanno muovendo Governo, Istituzioni regionali e locali che hanno deciso di investire sul turismo lento come strumento indispensabile alla promozione efficace e sostenibile del territorio, alla destagionalizzazione dell’offerta, al contrasto del fenomeno di spopolamento delle aree interne e alla creazione di nuovi posti di lavoro.  C’è ancora molto da fare per dar vita ad un sistema integrato, in cui vengano riqualificati e valorizzati i cammini esistenti, creati nuovi sentieri, piste ciclabili, percorsi enoturistici, segnaletica, itinerari ed esperienze culturali. Va rafforzata la comunicazione, sollecitando la voglia di scoperta di territori con le ricchezze paesaggistiche, artistiche e gastronomiche, realizzando punti di interesse lungo gli itinerari e indicando ai camminatori eventi, luoghi e occasioni di incontro. Ma una rete esiste già e può essere valorizzata. Su scala europea protagonisti sono i grandi itinerari religiosi come il Camino de Santiago e la Via Francigena che attraversa Inghilterra, Francia, Svizzera e anche l’Italia (in 10 regioni e 400 comuni) e potrebbe diventare punto di riferimento dell’intera offerta nazionale del turismo lento nostrano. A livello locale accanto ai percorsi spirituali ciascun paese ne propone molti altri, nel nostro paese molti sono dedicati al mondo vino, ne sono significativi esempi il Sentiero del Barbaresco e i Cammini del Monferrato in Piemonte, il Cammino Balteo in Val d’Aosta, il Cammino del Bardolino in Veneto, i percorsi Vini e Cammini in Abruzzo, i sentieri del Sagrantino in Umbria, gli itinerari della Val d’Orcia in Toscana. Attraverso queste esperienze di slow tourism ci s’immerge tra colline e vigneti, si attraversano borghi storici, si possono fare piacevoli soste per degustare vino e altri prodotti locali, percorsi creati con l’obiettivo di valorizzare l’impegno appassionato dei produttori ed il loro legame unico con le terre che lavorano, un patrimonio culturale, opportunità per arricchire l’offerta turistica ma anche per il settore vitivinicolo che se terrà fede all’impegno nella direzione del turismo lento potrà nel tempo avere a disposizione una rete sentieristica enoica sempre più capillare e organizzata da far riscoprire, rivivere e da salvaguardare.
C’è ancora molto da fare per dar vita ad un sistema integrato, in cui vengano riqualificati e valorizzati i cammini esistenti, creati nuovi sentieri, piste ciclabili, percorsi enoturistici, segnaletica, itinerari ed esperienze culturali. Va rafforzata la comunicazione, sollecitando la voglia di scoperta di territori con le ricchezze paesaggistiche, artistiche e gastronomiche, realizzando punti di interesse lungo gli itinerari e indicando ai camminatori eventi, luoghi e occasioni di incontro. Ma una rete esiste già e può essere valorizzata. Su scala europea protagonisti sono i grandi itinerari religiosi come il Camino de Santiago e la Via Francigena che attraversa Inghilterra, Francia, Svizzera e anche l’Italia (in 10 regioni e 400 comuni) e potrebbe diventare punto di riferimento dell’intera offerta nazionale del turismo lento nostrano. A livello locale accanto ai percorsi spirituali ciascun paese ne propone molti altri, nel nostro paese molti sono dedicati al mondo vino, ne sono significativi esempi il Sentiero del Barbaresco e i Cammini del Monferrato in Piemonte, il Cammino Balteo in Val d’Aosta, il Cammino del Bardolino in Veneto, i percorsi Vini e Cammini in Abruzzo, i sentieri del Sagrantino in Umbria, gli itinerari della Val d’Orcia in Toscana. Attraverso queste esperienze di slow tourism ci s’immerge tra colline e vigneti, si attraversano borghi storici, si possono fare piacevoli soste per degustare vino e altri prodotti locali, percorsi creati con l’obiettivo di valorizzare l’impegno appassionato dei produttori ed il loro legame unico con le terre che lavorano, un patrimonio culturale, opportunità per arricchire l’offerta turistica ma anche per il settore vitivinicolo che se terrà fede all’impegno nella direzione del turismo lento potrà nel tempo avere a disposizione una rete sentieristica enoica sempre più capillare e organizzata da far riscoprire, rivivere e da salvaguardare.